«Camoscio, crescita esponenziale nel Parco dei Sibillini: cosa fare se lo incontrate

I camosci appenninici osservati nel Parco dei monti Sibillini
di Francesca Marsili
Sono 264 i camosci appenninici osservati durante il censimento estivo 2025 nell’area del Parco nazionale dei monti Sibillini, sottospecie endemica che ha rischiato l’estinzione. E’ una prima stima, dati più accurati sulla consistenza della popolazione arriveranno con quello del prossimo autunno. Alessandro Rossetti è il biologo del parco, ha curato tutti i progetti di reintroduzione del mammifero oltre ad aver partecipato al monitoraggio della scorsa settimana: «Siamo in una fase di crescita esponenziale, ci aspettiamo che la popolazione aumenti in modo significativo».
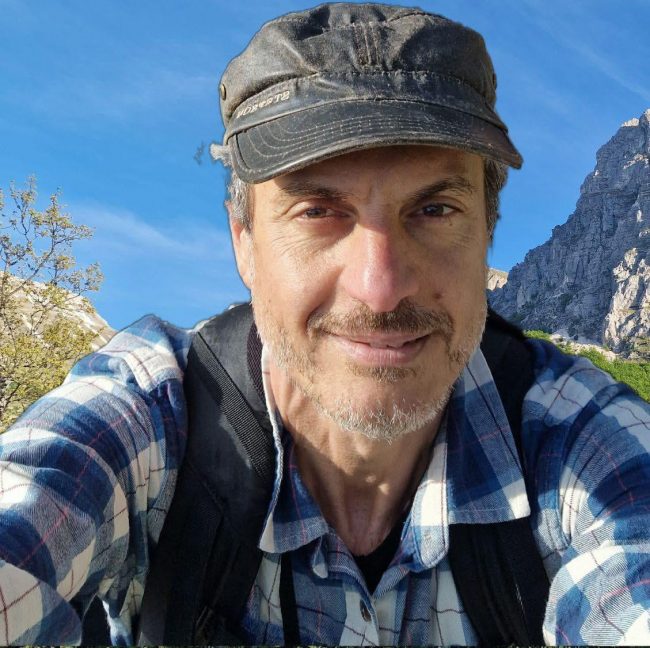
Alessandro Rossetti, biologo del Parco
Rossetti, quando è iniziata la reintroduzione?
«Nel 2008. Nel 2006 è stata realizzata l’area faunistica a Bolognola, nell’ambito di un progetto Life natura finanziato dall’Unione europea. L’obiettivo è quello di salvare questa sottospecie eclusiva dell’Appennino centrale, diversa da quella che troviamo sulle Alpi, e che ha sfiorato l’estinzione. Nei primi decenni dello scorso secolo ne erano sopravvissute pochissime decine di individui, una trentina. Si tratta di una specie particolarmente attenzionata anche a livello europeo, protetta da norme nazionali e internazionali».

Quanti censimenti occorrono per poter arrivare ad avere contezza della popolazione nel Parco?
«In un anno ne facciamo due, da cui ricaviamo delle stime degli animali presenti. Quello estivo viene fatto quando siamo abbastanza sicuri che sono nati tutti i camoscetti dell’anno. Le nascite avvengono tra maggio e i primi di luglio, quindi in questo periodo cerchiamo di contare anche tutti i piccoli. Poi ne viene fatto un altro in autunno, a fine ottobre: in questo periodo iniziano gli accoppiamenti e i maschi, che durante l’anno se ne stanno per conto loro, si uniscono ai branchi e possiamo contarli. Solamente dopo il secondo censimento, e integrando i dati con quelli raccolti costantemente durante l’anno dagli zoologi, riusciamo ad avere una stima completa».

Come avviene il monitoraggio?
«Con l’uso di fototrappole, ma soprattutto per osservazione diretta: il camoscio è infatti una delle poche specie di mammiferi in Italia su cui si può fare questo tipo di monitoraggio. Molti altri mammiferi hanno abitudini diverse, hanno vita notturna oppure si nascondono nei boschi e non è possibile contarli a vista. Il camoscio appenninico vive in ambienti aperti, in più è attivo durante il giorno e quindi visibile con la dovuta attrezzatura. Frequentano ambienti di alta montagna sempre vicino a rupi, il loro ambiente, in cui si difendono da possibili predatori come i lupi».
Cosa è emerso in quello estivo della scorsa settimana?
«L’attività si è svolta nelle aree ritenute idonee alla presenza, in alta montagna: sono stati avvistati 264 esemplari. Abbiamo iniziato all’alba e terminato nel primo pomeriggio. Hanno partecipato 23 volontari più 8 pattuglie dei Carabinieri forestali. Il giorno prima è avvenuto un incontro preparatorio con i volontari che si sono iscritti per partecipare a questa attività e che devono essere formati. L’ultima raccolta dati del 2024 vedeva una popolazione di circa 500 individui».

Alessandro Rossetti con alcuni volontari che hanno partecipato al censimento estivo 2025
In quale zona del Parco si concentrano?
«Tuttora la gran parte della neocolonia vive nell’area del monte Bove: quasi tutti i camosci presenti nel Parco vivono nel territorio maceratese. Il dato importante è che quest’area, che sulla base del piano di idoneità redatto nel 2004 era stata individuata come quella più idonea, nella realtà si è rivelata come quella giusta, come confermato dalla loro presenza. Non se ne sono andati, sono rimasti a riprodursi qui. Ma da qualche anno, visto che la popolazione sta aumentando, stanno iniziando a colonizzare altre zone e ad occupare nuovi territori come l’area del monte Priora».

Una gran bella soddisfazione, ci lavorate da quasi 20 anni…
«E’ sicuramente un progetto che ha avuto grande successo e che sta garantendo la conservazione di questo animale esclusivo dell’Appennino centrale. E ci è stato riconosciuto: abbiamo ottenuto un premio dal Wwf Italia ma anche dalla Commissione europea, chiaramente insieme ad altri parchi perché quasi tutti i 31 camosci immessi sono stati traslocati dai Parchi Nazionali abruzzesi: d’Abruzzo, Lazio e Molise, della Majella e del Gran Sasso e Monti della Laga. Sebbene il rischio di estinzione sia più lontano, il camoscio appenninico resta ancora vulnerabile. Negli anni in cui ne erano rimasti pochissimi individui la riproduzione è avvenuta tra conseguinei, con conseguente “erosione genetica” che espone la popolazione di camoscio appenninico a maggiori rischi, come ad esempio in caso di epidemie. La strada è ancora lunga e richiede un costante monitoraggio e una gestione attenta dei fattori di disturbo».

Siamo in periodo di ferie, c’è una grande riscoperta della montagna, soprattutto dei nostri monti Sibillini. Quali regole devono seguire i fruitori della montagna e come è giusto comportarsi se si ha la fortuna di incontrare queste meravigliose creature?
«Premetto che il progetto ha avuto un grande successo per la conservazione della specie che era sull’orlo dell’estinzione, ma si è rivelato molto importante anche per la valorizzazione del territorio. Si percepisce che la presenza del camoscio sui Sibillini viene vista come una cosa positiva: ci sono tante persone che arrivano appositamente per poterli vedere e tanti fotografi che cercano di catturare il momento.
E questi sono aspetti collaterali positivi: creano anche un indotto economico. Però, quando si visitano questi luoghi particolarmente sensibili del Parco nazionale, bisogna sempre fruirli con la dovuta conoscenza, responsabilità e sensibilità. La prima cosa da fare quando si programmano attività all’interno del Parco è quella di informarsi sulle norme vigenti.
Nell’area del monte Bove per esempio, quella più sensibile per la presenza del camoscio, non si può entrare con il cane, né in mountain bike, ma solamente a piedi.
Vietato far volare il drone e questo vale per tutto il territorio: è un elemento di forte disturbo per il camoscio che riconosce in tutti gli oggetti che volano una possibile minaccia, li riconduce all’aquila reale, che è un potenziale predatore di questi animali, soprattutto dei piccoli. E’ poi buona norma seguire sempre il sentiero: cosi facendo gli animali si abituano alla presenza umana.
Quando ci sono situazione prevedibili non risultano disturbati, accettano bene l’uomo. Dal sentiero è anche molto facile incontrarli. Infine non lasciare rifiuti organici che possano attirare i camosci, non è il loro alimento naturale; ancora peggio cercare di avvicinarli offrendogli del cibo.
Se si incontra un branco di camosci si possono osservare senza farli fuggite; è consigliato avere un binocolo.
Non bisogna andargli incontro, oltre che disturbarli li facciamo allontanare. La cosa migliore è fermarsi e non urlare; con un comportamento consapevole possiamo godere pienamente del magico incontro con il camoscio appenninico».
Torna alla home page
Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.
Effettua l'accesso oppure registrati
- 10 Dic - Mostra di artisti sordi nel Piceno, a sorpresa arriva l’attore Fabio Troiano (0)
- 10 Dic - Incendio in un appartamento: vigili del fuoco salvano una donna (0)
- 10 Dic - Dal 3 agosto 2026 le carte di identità cartacee non saranno più valide (0)
- 10 Dic - Sicurezza sul lavoro, Cedam e Edilart ricevuti dal Prefetto di Ascoli Piceno (0)
- 10 Dic - Cupra, la passeggiata di gruppo dalla spiaggia alla collina è un successo (Foto). Nuove date nel 2026 (0)
- 10 Dic - Palariviera, i film della settimana (0)
- 10 Dic - “Natale al Centopercento”, ecco gli eventi del weekend (0)
- 10 Dic - “Restare, partire, tornare”, il roadshow sulla ricostruzione (0)
- 10 Dic - Monte Piselli, D’Angelo riaccende la polemica con Fioravanti: «Forse dovrei tornare a fare lezione agli ascolani» (0)
- 10 Dic - Totosindaco, tante ipotesi per un voto che sarà come un derby delle urne (0)
- 10 Dic - Tre giorni per il futuro degli archivi: cultura digitale e partecipazione al centro del progetto “Metroborgo” (0)
- 10 Dic - Chiusura del corso di infermieristica, Curti: «Presenterò un’interrogazione urgente al ministro» (0)
- 10 Dic - Urbanistica, De Berardinis dirigente ad interim (0)
- 29 Dic - Raid di furti: villette prese di mira in via Don Milani (0)
- 10 Dic - Scontro aperto su Monte Piselli, Fioravanti accusa D’Angelo: «Ennesimo tentativo di distorcere i fatti» (0)
- 10 Dic - In memoria di Roberto: «Aiutateci a trovare una casa per i suoi cani» (0)
- 11 Dic - Dal sole alla pioggia torrenziale, il pazzo autunno del Piceno (0)
- 10 Dic - D’Alesio prova a trovare l’incastro giusto: dentro il 3-5-2 da schierare a Pontedera (0)
- 10 Dic - Ascoli, anche a Guidonia quasi 600 tifosi al seguito: è il quarto sold-out esterno di fila (0)
- 10 Dic - Camera Marche, incontro con il professor Gregori (0)
- 21:59 - Raid di furti: villette prese di mira in via Don Milani
- 19:23 - Dardust firma la colonna sonora ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026
- 18:25 - Zes nelle Marche: domande per 69,8 milioni di investimenti. Chiesto un incontro per la Carta aiuti
- 16:46 - Ascoli protagonista su Rai3 nella nuova puntata di “Radix”
- 16:22 - Si ribalta con l'auto: paura per una 22enne
- 15:55 - La Samb si blinda: «Nel girone di ritorno daremo battaglia su tutti i campi»
- 13:33 - Controlli Nas, pugno duro nel Piceno: maxi-multa a Monsampolo e attività sospese ad Ascoli
- 12:20 - Natale solidale: i soldati del Reggimento Piceno in campo per i bimbi più bisognosi
- 10:50 - Centobuchi apre il 2026 con “Storie e Illustrazione”, tre giorni dedicati ai libri illustrati
- 09:49 - Sociale, disabilità e famiglie: all’Ambito 21 risorse per oltre un milione di euro
- 08:54 - Ascoli, si riparte: archiviata la sosta, nel mirino c’è di nuovo la Pianese
- 18:04 - "Per grazia ricevuta": le tavolette dipinte (ex-voto) conservate nei santuari
- 16:28 - Associazioni giovanili si incontrano sul campo di calcio e vince lo stare insieme
- 15:27 - Lutto nel Piceno per Rocco Nota, storico insegnante e figura centrale della sinistra ascolana
- 14:22 - Urbanistica, Cardilli: «Più tempo ai Comuni sulle varianti puntuali ai Prg»
- 13:09 - Accerchiato e pestato dal branco: 16enne trasportato al pronto soccorso
- 12:08 - Vola per 15 metri in una scarpata: grave incidente a Massignano
- 09:43 - Lutto a San Benedetto per Domenico “Mimmo” Carnicelli
- 09:25 - Bomba carta nella notte, paura in via Aspromonte
- 08:47 - Dea Alzapiedi compie 100 anni: grande festa con famiglia e amici
- 25 Dic - Tragedia di Natale nel Piceno: muore a 58 anni Gabriele Talamonti
- 20 Dic - Duomo stracolmo per l’ultimo saluto a Pasquale Allevi (Video e Foto)
- 22 Dic - Addio al dottor Allevi, il messaggio della famiglia: «Ci avete restituito ciò che nostro fratello ha sempre donato»
- 23 Dic - Ragazzo di 17 anni si schianta in moto: ricoverato in codice rosso
- 20 Dic - Completamente nudo sotto l’albero di natale in centro: soccorso un uomo
- 27 Dic - L’ultimo saluto a Gabriele Talamonti: chiesa piena e tanta commozione
- 21 Dic - Centro storico pieno, portafogli leggeri: Fiera di Natale a metà
- 29 Dic - Controlli Nas, pugno duro nel Piceno: maxi-multa a Monsampolo e attività sospese ad Ascoli
- 25 Dic - Serie su Melania Rea, il fratello: «Ricordarla è un atto di responsabilità»
- 28 Dic - Lutto nel Piceno per Rocco Nota, storico insegnante e figura centrale della sinistra ascolana
- 25 Dic - Incidente di Natale sull’A14: auto si schianta nella galleria San Basso
- 23 Dic - Scritte sui muri contro una studentessa, la madre: «Una vera persecuzione, mia figlia non ce la fa più»
- 22 Dic - Tornano le scritte contro la studentessa, colpita la scuola di via Faleria
- 28 Dic - Lutto a San Benedetto per Domenico “Mimmo” Carnicelli
- 27 Dic - Samb: si preannuncia un mercato movimentato tra entrate e uscite
- 24 Dic - Gli addii da ricordare e una Cappella da valorizzare
- 22 Dic - Monterocco: «Il ritrovamento di beni archeologici impone cautela». Ma la variante viene approvata
- 22 Dic - Restano bloccati sul Monte Vettore: paura per due rocciatori (Video)
- 26 Dic - Fuga di gas e furgone in fiamme, Santo Stefano di superlavoro per i vigili del fuoco
- 21 Dic - L’Ascoli sbatte sul muro del Campobasso: 0-0 nell’ultimo atto del girone d’andata e del 2025






 Rss
Rss Facebook
Facebook