Risse tra baby calciatori e genitori, lo psicologo: «Il calcio deve restare un laboratorio di vita»
di Luca Capponi
Una partita di calcio giovanile trasformata in rissa, con genitori e ragazzi di 12-13 anni coinvolti in episodi di violenza. L’episodio, che richiama altri simili fatti di cronaca, è solo la punta dell’iceberg di un malessere profondo. A spiegarlo è Daniele Luciani, psicologo dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale dell’Ast di Ascoli, da anni impegnato nello studio dell’adolescenza. Ma non solo, perché nel tempo ha pubblicato diversi trattati di psicologia e, da qualche mese, è divenuta figura di riferimento per genitori e baby calciatori della Piceno Football Team, che con lungimiranza ha deciso di investire su una figura del genere, in grado di supportare ragazzi e famiglie.
«Lo sport – sottolinea Luciani – è uno degli strumenti più potenti per educare i ragazzi. Un campo da gioco non è soltanto il luogo in cui si corre dietro a un pallone, ma un contesto ordinato da norme simboliche: ci sono regole da rispettare, allenatori da cui imparare, compagni con cui collaborare, avversari con cui misurarsi. In questo spazio delimitato, i giovani imparano a contenere aggressività, narcisismo, pulsioni autodistruttive che abitano il corpo. È un laboratorio di crescita che consente di provare cosa significhi stare al mondo».
Secondo Luciani, però, perché ciò accada è necessario che allenatori e dirigenti abbiano chiaro il proprio ruolo: «Non basta insegnare tecnica o tattica. Chi guida i ragazzi deve essere consapevole di essere un educatore. Un allenatore deve diventare un punto di riferimento, perfino un sostituto genitoriale. Per questo è fondamentale che sappia trasmettere valori come rispetto, disciplina, umiltà, empatia, cultura del sacrificio e accettazione del fallimento. L’errore più grave, soprattutto a livello giovanile, è trasformare il calcio in una corsa al risultato. Così, si rischia di rovinare gruppi di amicizie, di far sentire inferiori alcuni ragazzi e di instillare la logica del successo a tutti i costi che possono produrre comportamenti che eccedono la dimensione ludica ed educativa dello sport. Ma i bambini hanno diritto di vivere il calcio con gioia, senza diventare professionisti troppo presto».
Lo psicologo ricorda anche che la pratica sportiva porta benefici tangibili: «Lo sport migliora l’autostima, riduce stress e ansia, regolarizza il ritmo sonno-veglia. Numerosi studi dimostrano che l’attività fisica in età scolare previene l’abuso di alcol, tabacco e sostanze. Ma soprattutto consente ai ragazzi di misurarsi con i propri limiti e con quelli degli altri in modo autentico, di costruire legami veri e profondi, di allenarsi a svincolarsi dalla famiglia per inserirsi nel discorso sociale».
Il nodo, però, va oltre il terreno di gioco. Luciani parla di una «adolescenza postmoderna» sempre più fragile.
«Se un tempo il percorso adolescenziale, pur complesso, era una tappa fisiologica verso l’età adulta, oggi sembra essersi trasformato in una condizione permanente e “patologica” – aggiunge – . Molti ragazzi scelgono di non scegliere: hanno paura della libertà, perché scegliere davvero significa rinunciare a qualcosa, venire a patti con il proprio narcisismo, accettare frustrazioni, mettersi in dialettica con l’altro, anche se quest’ultimo può rivelarsi una delusione. Scelgono inconsciamente di restare figli dentro la famiglia e consumatori dentro la società. Ma questa non è crescita: è un blocco».
La famiglia, secondo Luciani, ha un ruolo centrale in questa crisi: «Assistiamo a genitori che fanno fatica a imporre regole, che preferiscono essere amati piuttosto che rispettati. Non sanno più dire no perché non sanno più dire sì. Non offrono ai figli un modello positivo di come attraversare la vita con un progetto, un desiderio, una passione. Troppo spesso coltivano il mito del figlio ideale, alimentando il narcisismo proprio e dei ragazzi, senza insegnare ad accettare imperfezioni e limiti».
La società del consumo, la tecnologia e pandemia hanno accentuato queste dinamiche.
«I social e gli schermi sono una parte del problema – chiarisce Luciani – perché danno l’illusione che sia semplice costruire i legami, al prezzo di disumanizzare l’altro e non implicarsi soggettivamente con i suoi sentimenti, fragilità, inclinazioni; con la sua storia tout court. Così i ragazzi si abituano a rapporti superficiali, che per esempio possono essere interrotti con un click, senza imparare a sostenere la fatica di relazioni autentiche, senza assumersi responsabilità nei confronti dell’altro che, per la logica dei social (che riprende quella del consumismo), può diventare facilmente un oggetto da maltrattare o scartare. Poi arriva il Covid e taglia di netto le occasioni di socialità: niente sport, niente scuola in presenza, niente gruppo dei pari. È stata un’interruzione drammatica proprio di quelle prove che aiutano a staccarsi dalla famiglia e a diventare adulti. La pandemia ha sbattuto in faccia a tutti, giovani compresi, la fragilità della vita, mostrando che il senso dell’esistenza non è dato ma va costruito. Non a caso molti ragazzi, come tanti adulti, ne sono usciti disorientati e soli».
Le soluzioni, per Luciani, devono essere corali: «Famiglia, scuola, società sportive, associazioni presenti sul territorio e le istituzioni tutte devono lavorare insieme. La scuola deve recuperare la sua funzione educativa, insegnare empatia, comunicazione, gestione delle emozioni, non solo nozioni. Gli allenatori devono essere formati come educatori, i genitori devono avere il coraggio di imporre limiti, accettando di non essere sempre amati. E la politica deve restituire ai giovani spazi, opportunità e responsabilità reali, renderli protagonisti, perché solo così l’età adulta tornerà a essere desiderabile».
E conclude con un monito che suona come un invito agli adulti.
«I ragazzi si salvano se incontrano educatori capaci di coltivare le loro passioni – conclude Luciani -. Lo sport, il calcio, l’arte, la musica: sono strumenti che danno senso alla vita e che consentono di costruire dei percorsi alternativi rispetto a quelli disfunzionali che possono nuocere a se stessi e agli altri. Ma per funzionare servono, oggi più che mai, adulti disposti a lasciare spazio, a cedere il passo e a consegnare simbolicamente il testimone, proprio come accade in una staffetta. E servono ragazzi che desiderino raccogliere questo testimone, cercando di trovare il coraggio di incontrare il mondo degli adulti, anche attraverso una critica sana, ma costruttiva delle reciproche mancanze. È un’utopia? Forse. Ma senza questa disponibilità da parte di entrambi, continueremo ad avere adulti incapaci di educare veramente e adolescenti fragili, spaventati e arrabbiati. E i fatti di cronaca ce lo ricordano ogni giorno».
Torna alla home page
Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.
Effettua l'accesso oppure registrati
- 4 Feb - Accessibilità e inclusione, Monteprandone nella rete “Iacom” (1)
- 2 Feb - Dal “Bakkajamento” al tartufo: Force riscopre le proprie radici (0)
- 2 Feb - Piazza della Viola, cambiano viabilità e sosta: tutte le modifiche (0)
- 2 Feb - La città piange il dottor Gianni Ferretti (0)
- 2 Feb - Colli del Tronto, Luca Morganti candidato sindaco (0)
- 2 Feb - Una domenica sui pattini: oltre 90 atleti al Palazzetto dello Sport (0)
- 1 Feb - Non solo via Mare, anche via Virgilio: sottopassi sempre zuppi, problemi d’infiltrazioni e di sicurezza (0)
- 2 Feb - Non ha l’auto e nemmeno la patente
ma il passo carrabile lo deve pagare (0) - 1 Feb - Torino, scontri e feriti: tra gli agenti coinvolti anche un poliziotto ascolano (0)
- 1 Feb - Scontri a Torino: il Sap chiede sicurezza e certezza della pena (0)
- 1 Feb - Fabrizio Corona a cena in un noto ristorante del centro di San Benedetto (0)
- 1 Feb - Perdono l’orientamento sul sentiero tra Altino e Santa Maria in Pantano: salvati dai vigili del fuoco (0)
- 21 Feb - Le bellezze della montagna, ecco la ciaspolata sulla Majella (0)
- 1 Feb - Sfuma il colpaccio: Atletico Ascoli pareggia 2‑2 a Ostia contro la capolista (0)
- 1 Feb - Fabrizio Corona in Riviera: «Fonderò un movimento politico» (Video e foto) (0)
- 1 Feb - C’è già clima di Carnevale: festa e folla per la Domenica degli Amici (0)
- 2 Feb - Dilettanti, risultati e classifiche: Monticelli al cardiopalma, bene Atletico Azzurra Colli e Azzurra Mariner (0)
- 2 Feb - Inps, Lara Rampin nuovo direttore provinciale (0)
- 2 Feb - Occhio all’autovelox: i controlli di febbraio (0)
- 2 Feb - A14, arriva un’altra chiusura (0)
- 13:09 - Le bellezze della montagna, ecco la ciaspolata sulla Majella
- 11:54 - Ospedale dei Sibillini, si lavora per incrementare servizi e personale
- 11:12 - Tragedia lungo il Tronto: trovati morti due giovani in una tenda
- 10:44 - Sisma, confermato il differimento dei mutui e proroga Arera. Castelli: «Sostegni concreti»
- 09:53 - Scabbia nella Rsa, il sindaco convoca un incontro: «Servono soluzioni e trasparenza»
- 09:05 - Care vecchie edicole: Pietro Federici va in pensione
- 22:08 - «La nuova fontana di via Palermo? Sarà un bidè a cielo aperto per gli sbandati della stazione»
- 20:00 - "Spazi educativi di comunità": l’oratorio che educa, include e fa crescere
- 18:56 - "Pappa Fish", pesce fresco nelle mense scolastiche
- 18:27 - Centrosinistra, malumori dentro e fuori: «Partiti chiusi, consegnano la città alla destra»
- 18:18 - Motopesca “Pinguino”, il ricordo a 60 anni dalla tragedia
- 17:39 - Boscaglia traccia la linea: «Si gioca per la squadra e per la città, non per sé stessi»
- 17:38 - Imbarcazione scivola dalla banchina: intervento dei vigili del fuoco
- 17:02 - Pontedera-Ascoli, Tomei avverte: «Ennesima battaglia. Corradini out, ma sono contento di poter ruotare»
- 16:57 - Immigrazione, in Prefettura focus su integrazione e nuovo progetto “Cittadini in Rete”
- 16:33 - Elezioni, Gabrielli: «Scendo in campo con FdI. Veti? Non ne metto»
- 15:30 - Quintana, tra le novità un premio dedicato a Giacinto Federici: «Sarà un 2026 d'eccellenza»
- 14:14 - Più competenze, meno abusivismo nel settore del benessere: Cna rilancia con “Parliamone di lunedì”
- 13:21 - Montagna, Appignano e Castignano ancora esclusi: «Traditi dalle istituzioni»
- 11:44 - Anche l’elisuperficie di Montemonaco nella rete regionale del soccorso
- 18 Feb - Tragico schianto contro un albero, muore Adelina Reginelli
- 21 Feb - Tragedia lungo il Tronto: trovati morti due giovani in una tenda
- 18 Feb - Marco Merlini trovato morto in casa: aveva 50 anni
- 15 Feb - Carnevale ascolano al top: sfida la pioggia e si fa largo tra i cantieri (Video e foto)
- 13 Feb - Spari a Monticelli: identificato un 13enne
- 19 Feb - Auto fuori controllo centra vetture in sosta in viale Marcello Federici
- 12 Feb - Al via la consegna gratuita dei kit per la raccolta differenziata
- 16 Feb - Tutto nero attorno alla Samb: l’unica cosa buona è che non c’è più nulla da perdere
- 16 Feb - Perde il controllo dell’auto e sbatte contro il guard rail: ferita una donna, illeso il figlio 14enne
- 18 Feb - Pauroso schianto tra due camion in galleria: due feriti, code e rallentamenti tra Pedaso e Grottammare (Foto)
- 14 Feb - Lutto per Gianfranco Catalucci, anima silenziosa dello sport cittadino
- 17 Feb - Carnevale in Piazza: satira al sole tra cantieri infiniti, seggiovie immaginarie e supermercati vista cimitero (Foto)
- 11 Feb - Getta acqua sull’olio bollente, cucina in fiamme e palazzo evacuato: due residenti intossicati (Foto)
- 19 Feb - Le storie di Walter: Silvio Perla di Pretare
- 11 Feb - Carnevale e maltempo, slitta l’esibizione delle scuole
- 19 Feb - Ladri-acrobati flagellano la Vallata, nuovo colpo a Colli
- 11 Feb - Auto in fiamme, paura a Campo Parignano
- 13 Feb - Dal saltarello all’intelligenza artificiale: il “Carnevale delle Scuole” colora la città (Le foto)
- 13 Feb - Scontro tra scooter e auto sulla Bonifica: uomo in codice rosso
- 14 Feb - Carnevale, il centro si prepara: navette speciali per raggiungere il cuore della festa




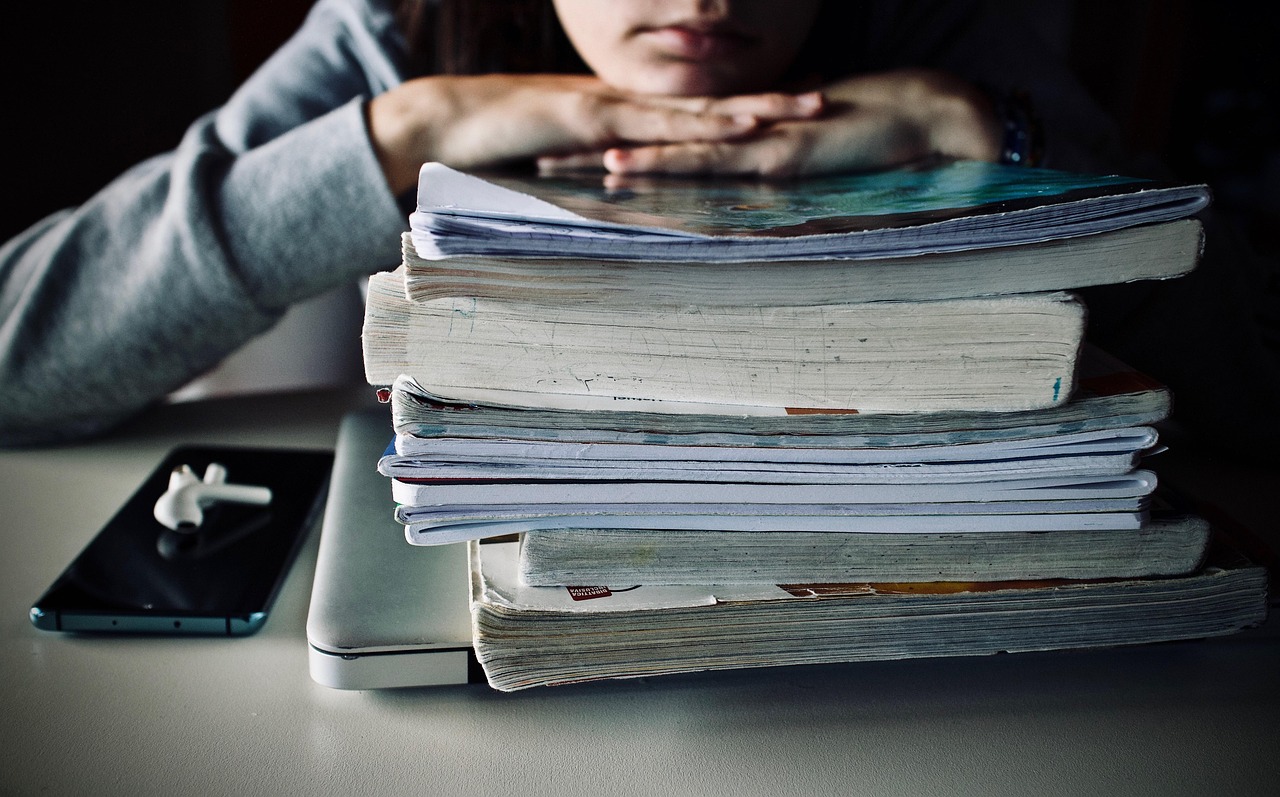





 Rss
Rss Facebook
Facebook