Sisma, Emidio di Treviri:
«Cosa ce ne facciamo della conoscenza?»

prof.ssa Rita Micarelli (GRASP – Gruppi di ricerca azione solidale partecipata) nel workshop “Progettazione eterodiretta e contro-progettazione dal basso” – Scuola Terza di Emidio di Treviri
Il progetto di ricerca “Emidio di Treviri” nasce nel dicembre 2016 da una call for research lanciata dalle Brigate di Solidarietà Attiva. Dottorandi, ricercatori, professionisti e accademici di vari settori aderiscono all’appello dando vita a un’esperienza di ricerca collettiva e autogestita capace di produrre conoscenza critica dal basso. A tre anni dal sisma propongono una riflessione pubblica sul ruolo della conoscenza nella ricostruzione: «Cosa ce ne facciamo della conoscenza?».
Ecco il testo della riflessione: «A tre anni dai sismi sull’Appennino Centrale la situazione è drammatica in maniera auto-evidente. Chi ci vive da queste parti la conosce bene. Chi non ci vive se ne accorge appena ci passa, dal silenzio delle valli, dal buio dei lampioni spenti, dagli odori che mancano. Una resa limpida ben più dell’ennesimo reportage fotografico, o di nuovi dati (che poi sarebbe bello un giorno avere quelli veri, ad ora in possesso di istituzioni pubbliche e imprese partecipate, che si rifiutano di metterli a disposizione della collettività).

Il basilico sacro a Sat’Emidio protettore dai terremoti, con le radici che formano una montegna
Questo tipo di produzione di conoscenza è molto utile per chi è fuori dalla bolla appenninica: sui social, nei mass-media, nelle università etc. queste rappresentano informazioni importanti, che circolano in determinate nicchie culturali e sottogruppi politici, e aiutano queste a farsi un’idea di uno spicchio del dramma generale in cui siamo immersi. Il problema è che contribuiscono poco o affatto al dibattito pubblico nei luoghi della montagna, da cui il dato, la notizia, la foto etc. vengono estrapolate.
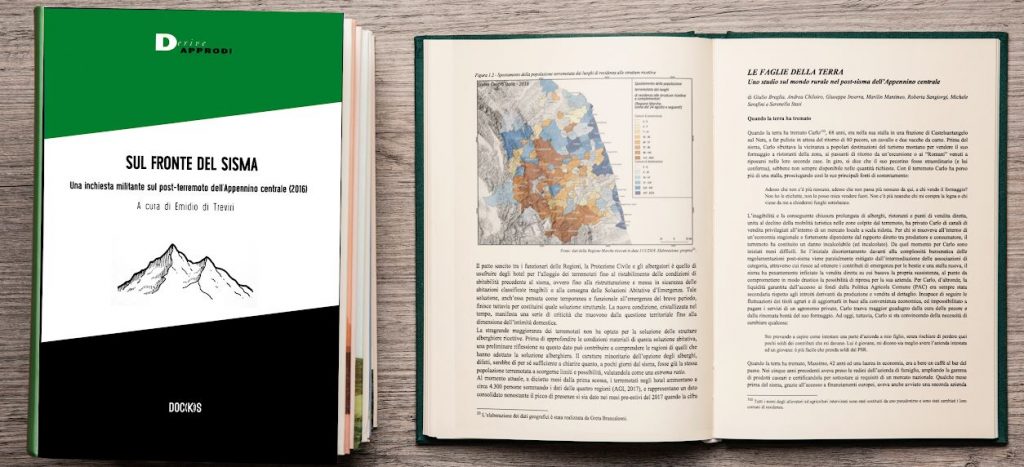
Il rapporto di ricerca scientifica indipendente sul post-sisma del collettivo
Per questo, già un anno fa dopo aver chiuso l’unica ricerca sull’emergenza di questi terremoti nel libro “Sul fronte del sisma”, il progetto di Emidio di Treviri ha scelto di non perseguire univocamente la strada della produzione analitica. Piuttosto, a partire da questa, muoversi verso traiettorie che hanno tentato di produrre diversi contro-piani. Li abbiamo chiamati gruppi di Ricerca-azione e sono stati impegnati (alcuni tuttora lo sono) a elaborare proposte che potessero rappresentare un punto di fuga verso cui proiettare quanto emerso dalle analisi sul campo. Hanno rappresentato una maniera per tentare di rispondere alla domanda: “e di tutte ste pagine di numeri, lettere e foto io, che me ne faccio?”.
Torna alla home page
Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.
Effettua l'accesso oppure registrati
- 13 Ago - Ex “Autostello” di Porto d’Ascoli: icona del boom economico da salvare (1)
- 30 Lug - Dissesto a Piattoni, situazione sbloccata per centinaia di abitazioni: ora si può ricostruire (0)
- 30 Lug - Dazi Usa al 15%, Confartigianato: «Accordo non indolore: c’è un export da tutelare per non perdere competitività» (0)
- 30 Lug - “Serafino story”, quando Arquata divenne un set: «Tutto merito di nonna Fausta» (0)
- 30 Lug - Interrogatorio fiume per Matteo Ricci,
cinque ore davanti al pm:
«Risposto a tutte le domande, sono sereno» (0) - 30 Lug - Ciclovia Adriatica, 27,5 milioni per il completamento: i primi tratti cantierabili (0)
- 30 Lug - Quintana: Priscilla, Francesca, Nicoletta, Beatrice e Arianna, le nobildonne del gruppo comunale (0)
- 30 Lug - Termina il ritiro di Cascia, l’Ascoli torna subito al lavoro al “Picchio Village” (0)
- 30 Lug - Csr e agricoltura resiliente: il presidente della Vinea D’Angelo fa il punto sul futuro del vino (0)
- 30 Lug - Brutto incidente sulla statale: giovane motociclista portato via con Icaro (0)
- 30 Lug - Samb, similitudini e diversità rispetto alle squadre di “ragazzini terribili” (0)
- 30 Lug - Regionali: rinuncia Donatella Ferretti (Forza Italia), Cardilli si candida per Fratelli d’Italia (0)
- 19 Ago - I pionieri del writing tornano insieme: un disegno che sa di anni ’90 e amicizia (0)
- 30 Lug - Pd, Elly Schlein a Force per la proposta di legge sulle aree interne (0)
- 30 Lug - Quintana, Alice Angelini sarà la castellana di Porchia: «Felice di tornare» (0)
- 30 Lug - Nuove sfilate a Piazza del Popolo: ad agosto torna “Moda sotto le Stelle” (0)
- 30 Lug - Folignano, successo per la sagra della tradizione: tre serate di musica e buon cibo (0)
- 30 Lug - Dazi, le ripercussioni su 2.500 imprese marchigiane. Il focus e l’allarme di Cna: «Necessari sostegni e compensazioni» (0)
- 30 Lug - Affidopoli, oggi l’interrogatorio di Matteo Ricci: l’ex sindaco è arrivato dai pm (0)
- 30 Lug - Assalto al bancomat con esplosivo: arrestati 3 uomini in fuga con 22mila euro (0)
- 11:21 - I pionieri del writing tornano insieme: un disegno che sa di anni '90 e amicizia
- 10:25 - Cantieri fermi e parcheggi bloccati: vie e piazze del centro ostaggi dei depositi edili
- 09:51 - Regionali, il M5S sceglie i candidati: 4 in lista per il Piceno, ecco i nomi
- 08:56 - Samb-Bra, si aspettano oltre 9 mila spettatori per il ritorno in Serie C
- 08:19 - Dal 15 settembre chalet aperti anche senza bagnini di salvataggio
- 19:50 - Scossa di terremoto nell’entroterra piceno: epicentro a 2 chilometri da Montegallo
- 19:29 - Al telefono un finto maresciallo, porta via 19mila euro a una donna
- 17:58 - Luca Innocenzi entra nella storia della Giostra dell’Anello
- 17:40 - L’oro rubato anche ad Acquaviva era nascosto nel tappo della benzina, clandestino fermato e denunciato dai carabinieri
- 17:13 - Derby Ascoli-Samb: "La grande abbuffata" dopo una lunga astinenza
- 16:59 - Grande festa a Castorano per i 100 anni di Assunta Gregori
- 16:15 - Strage di Gaza, cinque ore e mezza per leggere i nomi dei bambini uccisi
- 15:03 - Degrado al Ponterotto, Marinangeli a Pezzuoli: «Questione emersa grazie a me. Lui cosa propone di concreto?»
- 13:02 - Carenza di personale, l'Usb chiede l'assunzione di 24 infermieri e 13 oss
- 12:46 - «Determine controllate e chiare» La nota stampa della Svem in replica a Avs
- 12:20 - Ascoli, Tomei suona la carica: «Soddisfatto della crescita della squadra», ora testa alla Pianese
- 11:39 - Violento scontro tra auto e moto: uomo elitrasportato ad Ancona
- 11:16 - Fabbricati industriali, Ascolto & Partecipazione: «L'aliquota Imu non è rimasta invariata»
- 10:16 - Ovunque scritte sui muri: ecco come si presenta il centro di San Benedetto
- 09:14 - “La magia di un mito”: il progetto tv di Stefano Romani sui New Trolls conquista YouTube
- 10 Ago - Si schianta in moto contro un albero: morto un ragazzo di 27 anni
- 9 Ago - Tragedia a Colli del Tronto, Nazzareno Cantalamessa muore mentre fa jogging
- 11 Ago - Vandali distruggono pattino e ombrelloni, il titolare del lido: «Ho il filmato, offro una ricompensa» (Foto)
- 11 Ago - La morte del 27enne Simone Di Emidio gela Colli del Tronto: «Era un ragazzo conosciuto da tutti»
- 11 Ago - Notte bianca, il Wap non ci sta: «Shopping penalizzato». Protestano anche i titolari dei locali
- 12 Ago - Auto sottosopra sulla Circonvallazione: si è ribaltata dopo un incidente
- 10 Ago - Ascoli, record di abbonati: si viaggia verso la 2ª quota più alta della storia
- 11 Ago - Ascoli-Samb, calcio e odio: quando il cervello va in fuorigioco
- 17 Ago - Fiamme in un capannone in zona industriale: salvato il cane che era all’interno
- 12 Ago - Ascoli-Samb e faide sui social, Campanelli: «Clima strano, lo sport è fonte di aggregazione sociale»
- 16 Ago - Trovata la donna dispersa tra i sentieri di montagna (Video)
- 13 Ago - L’ultimo saluto a Simone Di Emidio: il rombo delle moto squarcia il silenzio, i palloncini bianchi volano in cielo
- 13 Ago - Tragedia all’alba: scontro frontale, muore una donna
- 13 Ago - Ex “Autostello” di Porto d’Ascoli: icona del boom economico da salvare
- 16 Ago - È morto a 61 anni don Armeno Antonini, parroco di Offida
- 13 Ago - Samb pronta: finiti i biglietti di Curva contro Vis e Bra, salgono gli abbonati
- 9 Ago - Grosso incendio a Colli del Tronto: il lavoro dei Vigili del fuoco (Video e foto)
- 10 Ago - Arresto cardiaco in strada: due giovani intervengono col defibrillatore e gli salvano la vita
- 18 Ago - Scossa di terremoto nell’entroterra piceno: epicentro a 2 chilometri da Montegallo
- 9 Ago - Sotto esame l’associazione che da anni stanzia all’eremo di San Francesco: la Diocesi impone una svolta






 Rss
Rss Facebook
Facebook